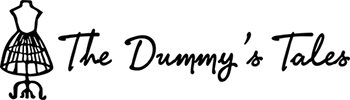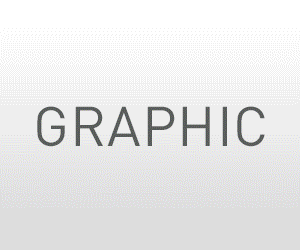La mia bisnonna si chiamava Eufrosina. Era nata in una poverissima famiglia greca, nella miseria di un piccolo villaggio rurale a un centinaio di chilometri da Atene e portava un nome che significava gaiezza, allegria, felicità. Ma la sua vita, al contrario, non era stata né gaia, né allegra, né tanto meno felice. Destinata in sposa, per via della sua sorprendente bellezza, a un ricco ebreo polacco si era trasferita a Varsavia all’età di sedici anni. Il suo aspetto etereo, la pelle diafana e gli occhi color ghiaccio, quei capelli lunghi di un nero sempre lucido, raccolti in un elegante chignon, e il suo profumo di borotalco facevano del mio bisnonno Blazej l’uomo più orgoglioso di tutti. Tanto che sempre e sempre ripeteva che l’investimento migliore lo aveva fatto con la traversata del mondo fino in Grecia per portarsi a casa una donna così bella da sembrare una divinità. Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale gli ebrei erano davvero una minoranza in Polonia. Per la maggior parte erano commercianti o bancari oppure erano impiegati nel settore tessile dell’abbigliamento e delle calzature. Erano quasi del tutto esclusi dagli impieghi statali, non avevano accesso ai lavori presso i servizi postali o le ferrovie e tanto meno potevano permettersi di fare gli insegnanti o i medici. Mia bisnonna mi raccontava spesso di come fosse radicato l’odio antisemita nella popolazione polacca e di come anche lei, di riflesso, fosse costretta a patire quell’asprezza di uomini contro altri uomini. Blazej dal canto suo era un abilissimo commerciante, fabbricava e vendeva cinture, scarpe e borse di ottima fattura che faceva proprio lui con le sue mani. E tutti lo lodavano nella capitale per la sua abilità negli affari, per il carattere affabile e il gusto raffinato. Stavano bene e erano felici con i loro sette figli prima che la Germania nazista si portasse via tutto e li cancellasse dal libro della vita. Blazej fece la tragica esperienza della deportazione e del lavoro coatto nel campo di concentramento di Auschwitz. Da lì non tornò mai più, gli toccò la fucilazione dopo lunghe sofferenze. Eufrosina, rimasta da sola con i suoi sette figli, negli anni del conflitto si vide morire tra le braccia i due più piccoli per il freddo e per la fame. Solo la femmina più grande e i quattro maschi riuscirono a sopravvivere. Gli altri no. Morti di stenti mentre la neve dei rigidi inverni polacchi entrava fin dentro le ossa. Fin dentro i polmoni e paralizzava il respiro. Fin dentro il cuore e anestetizzava il dolore. Nel dicembre del 1942, privata del suo Blazej e dei suoi piccoli Cyryl e Florjan, prigioniera dentro il ghetto di Varsavia, decise per vendetta nei confronti della vita che avrebbe odiato le emozioni per sempre. Perché odiarle era il modo migliore per tenerle lontane. Per allontanare la paura e il disprezzo. L’ira e la disperazione. L’angoscia e l’indignazione. Bisognava odiarle perché non facessero male. Era l’unico modo. E con loro bisognava odiare anche le illusioni: l’amore e la felicità. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, piena della forza del suo tormento, era arrivata in Italia, a Fadalto, dove aveva dei lontani parenti. Nel piccolo borgo montagnoso sopra Vittorio Veneto io l’ho conosciuta. In una casa fatta di sassi, che pretendeva di aggrapparsi alla natura circostante e pretendeva, senza riuscirvi, di aggrapparsi alla vita. Tutte le volte che ci incontravamo facevamo delle lunghe e silenziose passeggiate in mezzo ai boschi. Il nostro silenzio era rotto solo dal mio dirle “Ti voglio bene” e dal suo rispondere:
Io non posso volertene perché ho deciso tanto tempo fa che avrei per sempre odiato le emozioni.
Sempre quello stesso identico scambio, tutte le volte che ci vedevamo. E sempre quella stessa identica richiesta quando tornavamo dai boschi.
“Mi porti in soffitta a leggere i tuoi diari?”
“Perché vuoi che te li legga ancora?”
“Perché voglio imparare anche io a odiare le emozioni.”
“Va bene allora andiamo” diceva lei senza esitazione.
E insieme, pensierose, salivamo le scale che portavano alla soffitta. I suoi diari erano tutti scritti in greco e raccontavano i giorni spietati della Polonia durante la guerra. Ma raccontavano anche dell’amore per il mio bisnonno.
Caro Blazej custodisco nel mio cuore impietrito dal dolore il ricordo della nostra vita passata, di quello che è stato e che non potrà mai più essere. Non me ne volere se da Lassù mi senti bestemmiare questo Dio inutile e impotente, prostrato come uno schiavo ai piedi degli orrori della guerra. Il mio già povero cervello ha smesso di pensare e il mio cuore addolorato ha smesso di sentire. Ma l’ho scelto io. Con convinzione ho scelto di non sentire più niente. Da quel giorno in cui ti hanno portato via, perché non ho potuto smettere di avere impressa l’immagine dei tuoi occhi certi di andare incontro alla morte. Pieni di dignità fuori. Pieni di terrore dentro. Quei tuoi occhi li ho dovuti nascondere da qualche parte perché non mi facevano più vivere e non mi davano la forza disumana che mi serviva per andare avanti in qualche modo e per pensare ai figli rimasti. Insieme ai tuoi occhi ho nascosto tutto il resto. E mentre lo nascondevo lo odiavo. E odiavo così la paura e la disperazione. L’ angoscia e la nostalgia. La felicità e il nostro amore. Odiavo lo stesso odio. Odiavo tutto per allontanarmene. Da quel giorno ho imparato a vivere odiando le emozioni. Per poter finire i giorni che mi restano. Senza emozioni questa volta.
Quando terminava di leggere stavamo in silenzio a guardare la notte che scendeva da Fadalto giu’ verso la valle. E forse avremmo potuto piangere per la brutale crudeltà della natura umana. O magari ridere per la feroce insensatezza della vita. Ma noi odiavamo le emozioni. Per cui stavamo immobili a guardare la notte che scendeva.