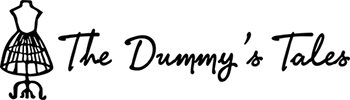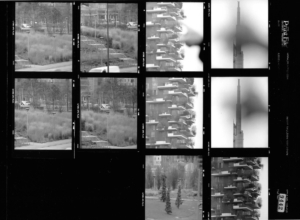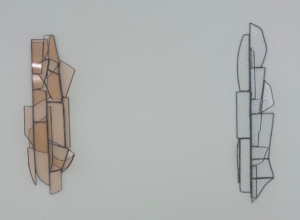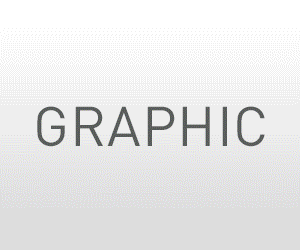L’incalzare dell’inverno portava con sé una serie di non trascurabili complicazioni, specie per una femmina. Le calze di lana pesanti, la gonna e le mutande erano un percorso ad ostacoli difficilissimo nel quale destreggiarsi prima di raggiungere il bagno. Spesso il tempo era tiranno e nell’indugiare, ecco, le mutande si facevano bagnate. I maschi no, i maschi erano più fortunati. In piedi, velocissimi, facevano tutto in un attimo e mai un castigo, mai una punizione, mai a doversi vergognare per qualcosa di bagnato. Fu durante l’inverno della prima elementare, dopo una svariata serie di punizioni, che decisi di fare anch’io come i maschi, di imparare a fare la pipì in piedi. Con quella determinazione i mesi freddi passarono veloci tra equilibrismi temerari, acrobazie pericolose, studi di meccanica corporea finalizzati ad apprendere la fine arte del saper pisciare in piedi. E quando arrivò, l’estate mi trovò preparatissima lì bella dritta nell’orto di mia nonna a bagnare le foglie di insalata che mi davano l’impressione di patire un caldo che non lasciava tregua. Si era trattato di un gesto di autentico altruismo che mia nonna però non aveva apprezzato, tanto che aveva preso a rincorrermi minacciandomi con il battipanni, urlandomi che ero una femmina io. Una femmina e le femmine non si comportano così! Non fosse stato per tutto quel grasso che si trascinava dietro forse mi avrebbe anche raggiunta e probabilmente fatta a pezzi. Invece da lontano, col fiato corto, sbraitava di tirarmi su le mutande e di comportarmi come una bambina di quelle per bene perché a quello ero stata educata. Al bene. Tutta colpa del mio altruismo e di quell’insalata che provando ad aggrapparsi alla vita mi aveva dato come l’impressione di non riuscirvi. Avessi scelto con certa trascuratezza un bersaglio differente, che ne so un albero o un muro, avrei potuto anch’io essere veloce e sbrigativa come i maschi per il resto della vita. Invece niente. L’inverno successivo di nuovo le stesse non trascurabili complicazioni in mezzo a tutta quella roba, e le calze di lana e la gonna e le mutande. E il tempo continuava a essere tiranno per una femmina della mia specie che non voleva abbandonare l’impegnativo gioco di osservare per il bisogno di correre in bagno.
Anche l’amore era complicato per le femmine e sempre più facile per i maschi. Loro potevano vantarsi di amare moltissimo mentre questa moltitudine a noi non era concessa. Durante la ricreazione la capoclasse, una che pareva saperla tanto lunga, ci obbligava a fare il gioco delle coppie. Io la odiavo perché avrei voluto fare altro ma lei diceva che sempre ad una femmina doveva corrispondere un maschio da amare e allora non le pareva vero di prendersi per tempo con gli allenamenti. Per me era un gioco difficilissimo quello delle coppie, ma il sacrificio valeva bene poter copiare la soluzione dei problemi di matematica che tutti i giorni mi costavano un brutto voto. Difficile perché amavo tanti maschi e per tanti motivi diversi e tutti i motivi mi sembravano validi in egual misura. Amavo uno per la simpatia. Uno per la bellezza. Uno per l’intelligenza. Uno per la sua estrema gentilezza. E così via, e si può dire a ragione che li amassi tutti. Ma il gioco prevedeva di sceglierne solo uno, perché così si comportavano le femmine. Invece la varietà pareva essere prerogativa esclusiva dei maschi che nei loro bigliettini stilavano perfino la classifica delle preferenze. E facevano tutto un gran parlare e un gran ridere, un chiassoso andirivieni di bigliettini mentre le femmine se ne stavano in un angolo a piagnucolare, lamentando trascuratezze di vario genere. Ora, io non trovavo mai un maschio che sublimasse in sé tutte quelle caratteristiche: che fosse al contempo simpatico come Roberto ma bello come Marco o intelligente come Alessandro e gentile come Filippo. E per quello nel gioco delle coppie mi accoppiavo sempre, in forma epistolare si intende, con il più manchevole di tutti i maschi. Mancanza per mancanza mi dicevo, meglio scrivere sul bigliettino delle coppie il nome del più brutto, del più antipatico, del più cattivo, del più stupido. E fu così che finii per accompagnarmi ogni anno della scuola col peggio del peggio, con quello che non amavo ma intendevo fare felice evitando che rimanesse appeso alla sua giacca un bigliettino bianco senza il nome di una femmina. Però intanto amavo in silenzio anche un po’ di ciascuno degli altri, di tanti altri, proprio come facevano i maschi. E per quanto provassero a convincermi che era una cosa brutta, da non fare, quasi un peccato, a me i maschi parevano piuttosto felici. Pieni di tanto. Simultaneamente.
Anche i sogni erano di gran lunga più complicati per le femmine che per i maschi dato che loro non erano soliti annotarli. Quando il 14 agosto, puntuali, arrivavano le giostre quello era il momento in cui facevo un sacco di sogni e li scrivevo anche. Sogni che mettevo dentro un mondo bellissimo senza regole, senza scuola, senza orari, quello che Denis mi raccontava tutte le sere. Io e Denis, detto anche il giostraro, eravamo diventati col tempo grandissimi amici tra l’orrore generale e lo sgomento di mia madre che continuava a chiedersi cosa avesse sbagliato con me. Imperterrita e fedele al mio credo io amavo anche un po’ di lui. La sua libertà in special modo. Perché lui poteva guidare anche se aveva solo 10 anni. E poteva andare a dormire dopo mezzanotte. E viaggiare di città in città come fosse un adulto. Io proprio le amavo tutte quelle cose. E insieme a quelle amavo un pezzettino di lui. Allora dopo il terzo anno di quel nostro rapporto saldo, prima che lui se ne andasse, gli avevo lasciato una lettera bellissima con su scritti tutti i nostri sogni. Che saremmo partiti con la carovana per un giro intorno al mondo. Che la carovana l’avrebbe guidata lui che aveva già la patente mentre io avrei pensato ai libri, ai giochi, a fare le fotografie di tutte le cose che ci passavano davanti agli occhi. Solo che il 14 agosto dell’anno successivo, mentre stavo in piedi nel solito piazzale ad aspettare l’arrivo delle giostre, con una valigia piena di altri sogni scritti, le giostre non arrivarono. Né quell’anno né tutti gli anni a venire. Quando avevo spiegato alle altre la faccenda della lettera con i sogni si erano tutte date un gran da fare a convincermi che le lettere erano cose da femmine e che gli zingari, o giostrari come si diceva con disprezzo, non sapevano leggere e tanto meno scrivere perché loro non andavano a scuola. Con quella verità nelle orecchie per la prima volta mi ero lasciata andare a un pianto disperato che poteva anche sembrare il piagnucolare di qualche femmina. Cosa strana per me che piangevo sempre in silenzio, composta e muta, senza lacrime. E tutte loro raccolte intorno a me a persuadermi che era normale, che così doveva essere, che non dipendeva dall’essere zingari o giostrari o insomma di quella razza lì, ma che dipendeva dal fatto di essere maschi. Che i maschi erano così: egoisti, freddi, superficiali, con un amore nascosto in ogni angolo. E tutte credevano che io piangessi rivendicando una qualche sorta di esclusività, che in realtà io mai avevo desiderato, quando invece non sapevo come consolarmi di una vita in carovana senza libri né scrittura. Perché se i sogni non li sai scrivere e non li puoi fissare allora evaporano, si dissolvono e non resta più niente. E quando li vai a cercare non li trovi più, perché non sono scritti e passa il tempo e passano anche loro. E te ne dimentichi. Ti dimentichi poi anche di sognare.
Da quel giorno di vana attesa inciampo ogni mattina nel desiderio di pisciare in piedi, di poter amare un pezzettino di tutti senza per forza amare qualcuno e di non saper né leggere né scrivere così da non dover annotare i sogni e potermene finalmente dimenticare. Con indosso un vestito dentro il quale annego tanto è grande. Perché è da maschio. E io sono una femmina.
Ph. Nils Rossi
Mua Francesca Galantino
Hair Matteo Flora