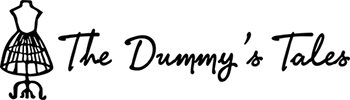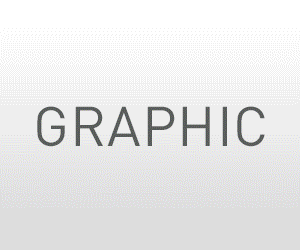E’ perché spesso il mio corpo è stato immobile, fermo e immobile sull’orlo delle cose. Mentre l’amore mi chiamava (ma non chiama tutti in verità?) da dentro la vita, mi costringeva a rinunciare all’immobilità dell’amore, a sacrificare il corpo a un desiderio di memoria. E’ per quello che io sempre ho guardato ai corpi, specie a quelli in movimento, e dentro il loro ritmo vi cercavo in qualche modo consolazione. La stessa che ho trovato in quella tua asciuttezza dolorosa che distillava gesti mutanti. E’ stata quella metamorfosi, narrata con la poesia visiva della tua arte, il continuo divenire delle tue figure inafferrabili che fluttuavano in uno spazio per certi versi rarefatto a chiamarmi. Da dentro la vita. Mentre io ero immobile. Sola nella mia fissità. Che provavo a farmi largo in mezzo a tanti coni d’ombra.
“E’ un corpo plurale il mio, corpo come mezzo. Quello che mostro, quello che concedo, è sì il mio corpo ma allo stesso tempo è un corpo. Ossia archetipo. E spesso nudo, perché nudi si è più forti. Spazio e luogo e confine tra il sé e il resto. Uscire con il proprio corpo (parafrasando Artaud), come se la pelle fosse stoffa, riconoscere l’impossibilità di poter abitare completamente l’involucro che ci rende manifesti, è già di per sé acquisizione del potere implicito in ogni corpo nudo. Si nasce nudi e nudi si è più forti. E si è più forti perché senza filtri, senza niente che rimandi a una certezza, ma piuttosto a un dubbio. Il corpo nudo fa sì che si dipani la questione che lo riguarda, è in perenne interrogazione (per se stesso e per chi lo guarda) e per questo totalmente scevro da ogni logica precostituita. Il nudo ha a che fare con la responsabilità del vedere, con la sottrazione di una lettura che coinvolge ogni sguardo. Non si spoglia un corpo della sua pelle e quindi, di fatto, un corpo nudo dichiara che non ha altro da togliersi. È la possibile verità, la schiettezza che si dà e si trova. Porta in sé la mimesis ontologica. Il nudo non è l’aspetto di un fenomeno, di un apparire perché non è nient’altro che sé, il suo stesso indizio. Il nudo, questo nudo, non trasgredisce niente, non imbarazza, non intende compiacere. Basta a sé.”
Un corpo chiuso dentro un dolore che non sapevo nemmeno io come dire. Male fisico che scorreva nel sangue ma poi rimaneva vittima esso stesso dell’immobilità onnipotente. Perché ogni minima trasformazione portava con sé sempre e comunque l’angoscia di non ri-conoscersi, di non appartenere. Abitare il corpo e forzarlo alla stasi. Non serve che dica, tu sai della sofferenza che vado appena tratteggiando.
“Il dolore – fisico o emotivo non fa differenza – è una componente di ciò che sono e del mio cammino. Non lo rifuggo, cerco di guardarlo, di somatizzarlo e di trasformarlo in qualcosa che sia vitale e non punitivo o inibitorio. Negli anni mi hanno attraversata molti dolori, sicuramente amplificati dalla mia sensibilità. Poiché è mio fedele compagno ho capito che questa fedeltà dovevo conoscerla, incanalarla e, sì, in qualche misura restituirla. Ogni forma di abbandono è un dono. Ed è un dono perché tutto ciò che ci dona l’esistenza ci rende ciò che siamo, più consapevoli di ciò che siamo e non siamo. Ogni forma di abban-dono, ogni forma di dolore è un’opportunità. Nostro compito è trovare – in ogni momento dell’esistenza – il giusto passo da adottare: passo di danza, passo di cavalcata, di pensiero. Non per cambiare noi stessi, ma per dare senso ed efficacia a ciò che siamo. In ragione di questo ogni cicatrice va solo benedetta.”
A un certo punto ho pensato che avrei dovuto farne poesia. Era quello il senso, poi divenuta urgenza di vita. Far danzare l’immobilità del corpo sulla carta, con l’inchiostro. Farlo muovere così, farne poesia. Scrivere della luce del meriggio che i miei occhi soli accoglievano. E del sapore dell’inverno dentro il quale capitolavo. E di un sentire strabordante e macro, sempre a inquadrare dal basso senza poter mai nemmeno intravedere la fine. Più tardi tutto questo farà parte di una poesia, mi son detta.
“Un poeta. Ecco. Se mai dovessi proprio soccombere all’esigenza di trovarmi un’etichetta (pratica che detesto) credo che sceglierei questa. Perché la poesia, così come la bellezza, è sempre crudele e niente ha a che vedere con una certa leziosità che spesso le si tributa. La poesia non è una maria che sfacchina per casa. Moltiplica gli occhi alle mosche e ruba ali ovunque può. Ali che poi si impigliano in tutto quello sparpagliare di altre ali – piume e penne, in ogni dove, come la gallina spennata dalla villana – nelle inferriate dei ballatoi, nelle strade, in quell’intersecarsi a voliera di tetti e comignoli. Una minaccia, vera e propria. É scossa tellurica durante il ballo in maschera del caos. Perché te ne stai lì, a cercare quella parola-immagine che non trovi, che si è ficcata chissà dove. Una parola-immagine che è già metastasi e che pretendi sia in grado già da sola di rammendare. E comprendi, per la prima volta, cosa sia il pudore. Perché nelle pieghe delle piaghe tutto è vergine e ogni fraseggio che ri-trovi lo associ ai miracoli e ai corpi: mutevoli in ciò che hanno fatto. Tuttavia un “poema” è sì un dono, ma un dono segreto che ha a che fare con le promesse e per questo alcune volte senti il pudore di ciò che crei. Che è come dire di ciò che hai dentro.”
E’ stato quando ho abbandonato certe architetture della colpevolezza, quando ho imparato ad accogliermi, ad accogliere con la stessa identica benevolenza miseria mia e grandezza, se mai ne fosse arrivata. Ecco, allora ho avuto di nuovo fame, ho avuto fame delle cose che vedevo. Lo sguardo smetteva di indugiare immobile sul vuoto, si spostava lento sulla vivida luce dell’ombra. E’ stato allora che il silenzio mio è diventato il grido di ribellione di cui dici.
“Rivendico il considerare ogni fragilità un autentico grido di ribellione. La nostra pelle è un involucro organico e come tale destinato a perire e a rinnovarsi. Non c’è mera fragilità, in questo, ma solo l’accettazione di quanto l’essere umano rechi in sé i concetti di fine e di cambiamento. Mutiamo interiormente e mutiamo fisicamente e spesso l’accorgersi di quanto questi due processi siano in simultanea rasenta un incontro che ha che vedere con lo ieratico. Ogni metamorfosi, ogni cambiar pelle esige dolore. Senza dolore il corpo (e il nostro dentro) non cambia. Le possibili gnosi che ne derivano possono variare da individuo a individuo, tuttavia nessun essere vivente è immune dall’alterazione di ogni possibile accento.”
Oh, ma la mente sa mentire, eccome se sa mentire. La mente diceva di partire, diceva sempre di andare. E di trascinarsi dietro solo un’immagine d’ombra, non un corpo. Qualche volta mi ricorderò di te, prometteva. E anche adesso, quando mi giro, è lì che ancora mi aspetta, senza un sorriso, per dirmi che il tempo risolve tutto.
“La mente può essere una grande menzognera. L’esperienza che ho con il mio corpo mi conferma ogni giorno che, al contrario, il corpo non inganna. La mente opera secondo acquisizioni e rimozioni, il corpo mantiene in ogni sua postura, in ogni suo atto, gesto tutto ciò che lo ha attraversato. La memoria del corpo è come un tracciato inconfutabile e quindi il linguaggio del corpo è l’autentico linguaggio della memoria. Il corpo non dimentica e ti rammenta di aggiustare il tiro. Ascoltarlo, viverlo significa quindi diventare presenti, coscienti a una forma di pensiero non edulcorata, non raffinata da processi unicamente cerebrali. Un piccolo dolore in una parte del corpo è la spia di un’emozione che abbisogna di essere guardata, appresa e alcune volte consolata. A sua volta è anche una forma di comunicazione fra il nostro modo di porci all’esterno, le nostre emozioni e la compenetrazione di questi elementi.”
Autonomia. Identità. Io. Costruirmi la mia pelle. Dargli un peso a quell’involucro. Non coprire più le cicatrici con la stoffa, ma farne pelle nuova. L’assoluta libertà di esplorarmi. Riscoprire l’immutabile dentro di me. Del mucchio di forme e sembianze sceglierne una. Io e me, che faticosa salita.
“Posso indossare maschere, là fuori, però maschere che non sono mai false…bensì semplicemente atte a celare e/o rivelare alcuni dettagli di me. Probabilmente anche questa è una forma di identità virtuale, ma non sapendo ancora di preciso quale sia la mia identità reale (e non sapendo sopratutto definire cosa possa essere reale o meno) lascio tutto abbastanza tributario a ciò che scelgo di mostrare. Volevo che per il progetto Other Identity, abilmente curato da Francesco Arena, fosse evidente quanto per me a restituire la dimensione identitaria non fosse tanto la componente somatica o fisiognomica quanto, invece, l’aderenza e la consapevolezza di un qualcosa che abbiamo vissuto e che ci ha vissuti. Se mai il mio lavoro debba essere un self-shot voglio che passi da vie più misteriose, vie che partono da una me al singolare e che divengono subito plurali, affinché ognuno possa scorgervi qualcosa di sé. In Other Identity ho portato tre foto del progetto Cicatrici e uno dei miei ultimi video: Uncalled for Anatomy. Cicatrici è un lavoro che ho avuto il coraggio di riprendere solo quest’estate. C’erano questi autoscatti (e autoscatto non significa autoritratto…è apertamente un modo di utilizzare il medium scelto) che risalivano a un periodo in cui il mio corpo mi aveva abbandonata. Avendo un corpo già di per sé esile dimagrire anche solo di alcuni chili comportò un cortocircuito del quale – tutt’oggi – ancora ne pago le conseguenze. Tuttavia da una delle finestre della mansarda nella quale vivevo spesso entrava una luce talmente seducente e lusinghiera che volli assecondare. Nacquero delle foto sfocate (non utilizzai i tempi lunghi, ma semplicemente nel momento di premere il telecomando per l’autoscatto mi mossi lentamente) che non volli guardare per molti anni. L’ho fatto mesi addietro, poi ho sovrapposto la stessa immagine più volte e ne è uscito un corpo in metamorfosi. Considero questo lavoro una specie di monito e credo che sia complementare al video in mostra nel quale un movimento spezzato del mio corpo (avvalorato da una scelta di passi dalle registrazioni vocali di Pour en finir avec le jugement de dieu di Artaud) rivendica un’identità consapevole delle proprie fragilità e sezioni non sempre in armonia fra loro, tuttavia vitali e a loro modo detentrici di un vigore consapevole perché accolto.”
Accogli il vigore con il quale, per mezzo del tuo corpo, mi sono concessa il privilegio di scrivere della mia pochezza. Di donna. Di lato. All’ombra della mia figura, il tuo lavoro ha dato dignità e vitalità nuova alle fragilità. Ma non le ho impresse sulla carta. Sono su quella foglia che forse non hai mai smesso di aspettare. E magari, in qualche modo, è arrivata. Così.
Desidero ringraziare la visual artist Eleonora Manca per avermi concesso di scrivere della sua arte e per tutto il non detto tra noi che poi è stato detto qui. Il suo lavoro si può vedere anche ai seguenti link: eleonoramanca.wix.com/eleonoramanca – Vimeo – Facebook.
In copertina: changes of questions_XXX_Eleonora Manca_2016

Distillando gesti mutanti_III_Eleonora Manca
Diario sporco_Eleonora Manca_2013
 Cicatrici_I_Eleonora Manca_2015
Cicatrici_I_Eleonora Manca_2015
Esercizio di muta n.11_Eleonora Manca_2015
Ephemeral_X_Eleonora Manca_2013
Before You Move_XXXVII_Eleonora Manca_2015
Anamorphosis_XXVI_Eleonora Manca_2015