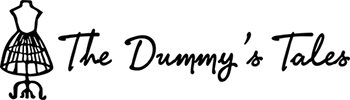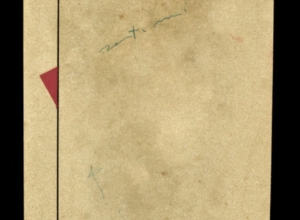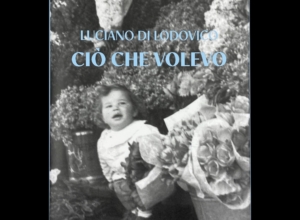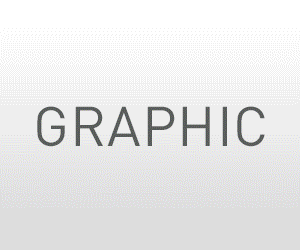Filippo Venturi (Cesena, 1980) è un fotografo documentarista che realizza progetti personali su storie e problematiche riguardanti l’identità e la condizione umana. I suoi lavori sono stati pubblicati sui più prestigiosi magazine e quotidiani e sono stati esposti in numerose mostre, sia in Italia che all’estero. Negli ultimi anni si è dedicato a un pluripremiato progetto sulla penisola coreana, che sarà in mostra a Riaperture – il festival della fotografia di Ferrara che inaugura il prossimo 10 settembre – e di cui abbiamo parlato in questa intervista.
Francesca Interlenghi: La condizione umana e la questione dell’identità sono i due grandi temi che attraversano il tuo lavoro. La fotografia diventa una grammatica con cui scrivere, con cui tracciare, le vicende umane. Mi puoi parlare del tuo approccio all’universo delle immagini?
Filippo Venturi: Dietro al mio incontro con la fotografia non ho una storia romantica o nostalgica, magari legata a qualche parente che mi ha introdotto a questo mondo regalandomi in gioventù una macchina fotografica. Il mio interesse è nato spontaneamente, attraverso l’osservazione casuale di fotografie e il desiderio di imparare a maneggiare quel linguaggio. Sono passato dalle fotografie di Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Luigi Ghirri, Martin Parr e tanti altri. Ma l’incontro che mi ha folgorato è stato quello con i lavori di Alec Soth. Col passare degli anni, e superando una certa timidezza che contraddistingue i fotografi, soprattutto ai loro inizi, il mio interesse è andato verso le persone, le loro storie e le problematiche sociali da cui venivano toccate; l’uso del ritratto ambientato è diventato una componente fondamentale di molti miei progetti, così come la raccolta di interviste e altro materiale. L’incontro con le persone è diventato fondamentale per me, come persona, come viaggiatore e come fotografo.
Francesca: Venendo al progetto “Korean Dream” mi puoi dire della sua genesi? Quando l’hai realizzato e quali i motivi che ti hanno spinto a documentare la realtà della Corea del Nord?
Filippo: ”Korean Dream” rappresenta per me il secondo capitolo del mio progetto sulla penisola coreana, il seguito di “Made in Korea”, il capitolo dedicato alla Corea del Sud. Ho iniziato a interessarmi alla Corea del Sud nell’estate del 2014, leggendo alcune notizie di attualità sul Paese. Continuando a informarmi, rimasi stupito dall’incredibile trasformazione che il Paese aveva vissuto negli ultimi 60 anni, passando dall’essere considerato “terzo mondo” ad essere uno dei Paesi più moderni e con una crescita economica incredibile. Ancora di più mi sorprese che, fra i miei conoscenti, ben pochi sapessero o fossero mai stati in Corea del Sud. La decisione di partire per realizzare un progetto (nel 2015, dopo circa un anno di studio e approfondimento) nacque quindi dalla voglia di raccontare qualcosa di poco noto, ma che meritava attenzione.
Dopo “Made in Korea” mi venne naturale pensare che sarebbe stato molto interessante riuscire a realizzare un progetto analogo nella parte nord della penisola. Ma la Corea del Nord non è facilmente accessibile e i tempi per trovare i contatti e riuscire a ottenere il visto giornalistico sono stati piuttosto lunghi. Nel 2017, dopo due anni di ricerche e richieste, finalmente, sono partito per Pyongyang insieme a una giornalista di Vanity Fair.
Francesca: In quale contesto ti sei trovato a dover svolgere il tuo lavoro?Filippo: La dittatura presente in Corea del Nord è la più rigida e chiusa al mondo, la narrazione è quindi complessa e, a volte, resa ulteriormente complicata da fake news messe in circolazione dalla contro-propaganda. Desideravo vedere coi miei occhi quella realtà che spesso viene accostata al mondo descritto nel romanzo “1984” di George Orwell. Volevo girare per Pyongyang e non solo, incontrare le persone, realizzare ritratti, raccogliere testimonianze. Quel che non avevo capito subito è che io stesso mi sarei ritrovato nelle stesse condizioni del popolo nordcoreano: sorvegliato 24/24 (di giorno da 3 guide che mi scortavano, più l’autista, di notte dai microfoni posizionati nella camera dell’albergo), controllato nel mio lavoro (una delle 3 guide era un fotografo che verificava i miei scatti e a volte mi ordinava di cancellarne alcuni), senza la possibilità di usare internet (in Corea del Nord non c’è l’internet per come lo conosciamo noi), potendo telefonare solo dalla hall dell’hotel (dove ogni sera chiamavo la mia compagna per dirle che stavo bene, senza dilungarmi troppo, sapendo di essere ascoltato), senza potermi informare (una notte però, nella TV in camera, scoprii che riuscivo a vedere il canale di notizie Al Jazeera, in inglese). Il viaggio si svolse a maggio 2017, quando la tensione fra Kim Jong-un e Donald Trump era alle stelle e il Presidente americano aveva affermato che qualsiasi opzione fosse sul tavolo, facendo intendere anche l’intervento militare, quindi l’atmosfera era abbastanza pesante. Se in quel momento poteva essere visto come sfortuna, una volta rientrato in Italia il mio lavoro ha suscitato un interesse immediato e amplificato proprio a causa del timore di una guerra imminente.
Francesca: Porti il progetto a Riaperture, il festival della fotografia di Ferrara, che quest’anno inaugura sotto la voce di Ideale. Ideale è ciò che appartiene o è proprio dell’idea, intesa come entità essenzialmente mentale e spirituale contrapposta alla realtà esterna. Come si manifesta questa contrapposizione nelle immagini che compongono il progetto?
Filippo: Se nel viaggio in Corea del Sud avevo pianificato ogni giornata, spostamento e incontro (lasciando comunque spazio agli imprevisti e alle opportunità, cosa inevitabile per un fotografo documentarista), in Corea del Nord non sapevo se sarei riuscito a lavorare. Sapevo che mi avrebbero ostacolato in diversi modi (lo avevo letto nei resoconti passati di altri fotografi e giornalisti e anche l’intermediario che mi aveva aiutato a ottenere il visto mi aveva messo in guardia): potevano preparare le persone che avrei incontrato e i luoghi che avevo indicato di voler visitare, le guide/controllori avrebbero fatto da traduttori nelle interviste potendo così censurare ciò che avrebbero ritenuto inopportuno. L’idea di come gestire tutto questo e riuscire a realizzare comunque un progetto efficace mi venne il primo giorno: fotografai la guida-fotografo mentre a sua volta mi fotografava; in quel momento capii che avrei potuto assecondare i miei controllori ed estremizzare col mio lavoro il mondo “ideale” che volevano apparisse ai nostri occhi, rendendolo evidentemente artificiale, poco credibile. Nei giorni successivi quindi ho continuato a riprendere soprattutto ciò di cui le guide erano orgogliose: asili, scuole e altri luoghi tirati a lucido, con evidente segnali della propaganda, persino l’esaltazione della potenza militare del paese da parte di bambini e tanto altro. I soggetti che mi era proibito fotografare, e a cui rinunciai senza problemi non trovandoli interessanti, erano eventuali segni di degrado urbano a Pyongyang, eventuali cittadini poco presentabili, cantieri edili e i militari (a meno che non mi autorizzassero prima loro stessi). Alla fine ho ottenuto ciò che speravo, cioè due lavori che assecondano i desideri dei due Paesi di apparire come delle eccellenze – nello studio e nel lavoro per i sudcoreani, a livello organizzativo e militare per i nordcoreani – estremizzandoli fino a farne emergere tutte le contraddizioni.
Filipo Venturi, sito – Facebook – Instagram
Tutte le immagini sono di ©Filippo Venturi. Ne è vietato l’uso o la riproduzione senza l’autorizzazione scritta dell’autore.