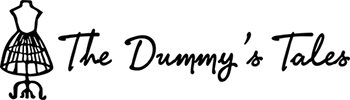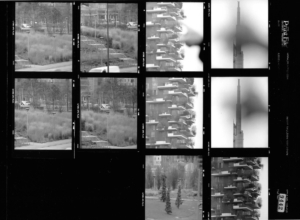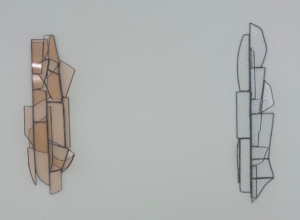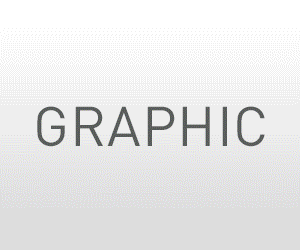C’è un nucleo duro, stabile, in questa serie di autoritratti in cui ogni luce porta con sé necessariamente la sua ombra. Immagini che non si impongono come orgogliosa affermazione della propria identità, che non vogliono reclamare con fermezza “questa sono io”, ma piuttosto cedere alla consapevolezza del “io non so chi sono”. L’autoritratto cristallizza una condizione che costituisce la parte segreta di persone e oggetti. E inseguendo quel sottile e labile confine posto tra visibile e invisibile, ci conduce in un mondo altro in cui il confronto con sé stessi è continuo e a volte doloroso.
Mile Giacomazzi si dedica alla fotografia di ritratto, in particolar modo di esponenti del mondo della cultura, all’autoritratto e alla fotografia d’arte, utilizzando prevalentemente il bianco e nero. Rivolge la macchina verso sé stessa o verso l’altro per creare, di volta in volta una sorta di teatro. Sue opere sono inserite nell’archivio del Fondo Malerba per la Fotografia di Milano, nel Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, nella fototeca della Biblioteca Baratta della città di Mantova, nel Museo Nori de’ Nobili di Ripe (Ancona) ed in collezioni private. Annovera esposizioni sia in Italia che all’estero. Della sua poetica abbiamo parlato in questa intervista.
Francesca Interlenghi: Mi puoi raccontare i tuoi inizi con la fotografia?
Mile Giacomazzi: Molto semplicemente, intorno ai 16-17 anni, mi sono fatta regalare dai miei genitori la mia prima reflex. Avevo già allora molta attrazione per la figura umana, per la persona, per l’atteggiamento, la postura, per il teatro che viviamo e creiamo. Il teatro della vita intendo. Ho iniziato a fotografare le amiche, in casa mia, e poi non so nemmeno io bene come da gioco, da passatempo e passione, è diventata la vocazione della mia vita. Un processo che è venuto da sé, non ho dovuto rifletterci in verità. Qualcosa che ho sentito. Ho capito in seguito che dovevo imparare la tecnica perché, per come la vedo io, è una componente importante della fotografia pur non essendo la totalità di una fotografia. Ottenere la propria cifra stilistica è anche una questione di tecnica. La mia è una foto rigorosa, pulita, senza grana. Una foto forte anche, diretta si potrebbe dire. Quindi la tecnica mi è servita per ottenere l’estetica che volevo. Poi certo te ne dimentichi, la superi in qualche modo, ma per farlo devi averla acquisita.
Francesca: So che il fotografo Angelo Roberto Tizzi, che tra le altre cose ha lavorato per diversi anni per Vogue ottenendo ottimi riconoscimenti, è stato un grande maestro per te. Forse il più importante.
Mile: Si, il mio grande maestro. Quando andavo da lui i nostri non erano solo discorsi fotografici, parlavamo d’arte e di tante altre cose. La fotografia non la puoi trattare solo da una prospettiva, è un discorso di vita, di arte, di anima. Non è solo immagine. Parlavamo di tutto. Poi chiaramente mi ha insegnato a usare mezzi anche importanti come il banco ottico. Lavoravo in lastra, con tempi del tutto diversi da quelli attuali. Sono arrivata tardi al digitale però ho cercato di ottenere la stessa intensità, lo stesso risultato che ottenevo con l’analogico e con un banco ottico che, parlando di ritratti, ti costringe a un approccio diverso con chi hai di fronte.
Francesca: C’è un legame strettissimo, in tutto il tuo lavoro, tra la parola scritta e l’immagine. Parti diverse, eppure uguali mi sembrano, di un unico esercizio di decodificazione della vita.
Mile: Io ho iniziato scrivendo in realtà, scrivendo poesie, ma quello che scrivo da sempre è anche quello che fotografo. C’è una correlazione importantissima tra parola e immagine, tanto che con il tempo sono passata a scrivere con la fotografia invece che con l’inchiostro. Quello che io scrivo è da sempre molto fotografico e molto intimistico ed è poi quello che esce in fotografia. E’ un bisogno che ho quello di esprimere ciò che sta dentro la mia mente e di usare il mio corpo e la sofferenza trasformandoli in qualcosa di altro e diverso.
Francesca: Il tuo corpo diventa un vero e proprio banco di sperimentazione. Grotowski ci insegna che il nostro corpo è la nostra vita. Nel nostro corpo, tutto intero, sono inscritte tutte le nostre esperienze. Sono inscritte sulla pelle e sotto la pelle, dall’infanzia fino all’età matura, e forse anche prima dell’infanzia e prima della nascita della nostra generazione. Il corpo-vita è qualcosa di palpabile. E forse anche di fotografabile, mi viene da aggiungere.
Mile: Lavoro su me stessa perché credo di averne sentito il bisogno. Il bisogno di diventare anche attrice, attrice di me stessa. Il corpo, il corpo immortalato nell’immagine, deve esprimere qualcosa: un sentimento, un’emozione. Mi interessa l’intensità. Più che la luce, la composizione o l’armonia, più che un corpo bello o brutto, grasso o magro, giovane o vecchio, cerco quell’intensità che mi fa dire di una fotografia: è mia figlia! Come se fosse una parte di me stessa che è uscita, si è rivelata. Che è finalmente venuta alla luce e che prima non esisteva.
Francesca: Ultimamente mi capita spesso di pensare all’arte come a un non luogo – luogo dello spirito, luogo del cuore – in cui, indipendentemente dal medium utilizzato, avviene in qualche modo la ricomposizione dei frammenti. Quelli nostri, in special modo. In definitiva, diresti che la fotografia è una possibile cura?
Mile: Più che cura intendo l’arte come rifugio, in cui si provano attimi che credo di credere siano di felicità.