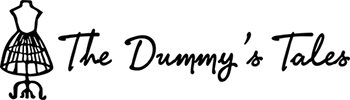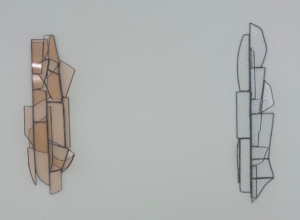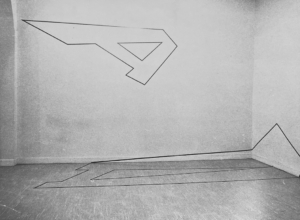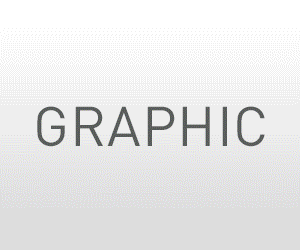Dal 5 ottobre all’11 dicembre 2022, a Reggio Emilia presso Binario49, l’artista Caterina Notte (Isernia, 1973) presenta l’installazione sonora “La mia voce dentro il mare”. L’opera fa parte del progetto “Cercando la libertà. Storie di diritti negati, le pratiche di resistenza delle donne dall’Afghanistan all’Europa”, curato da Benedetta Incerti con lo scopo di accendere i riflettori sui conflitti dimenticati e sulle storie delle donne che li hanno vissuti sul proprio corpo mettendo in atto pratiche di resistenza.
Artista multimediale che si esprime attraverso la fotografia, il video, la performance e la scrittura, Notte indaga il tema della fragilità della condizione umana, della donna in particolare, quello dei legami che regolano le dinamiche, spesso distorte, delle relazioni interpersonali e quello della libertà intesa come tensione verso la ricostruzione di un primigenio stato esistenziale scevro da condizionamenti e sovrastrutture sociali. L’artista inizia la propria indagine scansionando il suo corpo per scomporre e ricomporre digitalmente la sua immagine, manipolando la risultante attraverso l’uso di photoshop, trasformandosi lei stessa in una sorta di cavia, terreno fertile di una ricerca che insiste sul carattere costrittivo, fatto di credenze limitanti, che definisce il nostro vivere.
© Caterina Notte, Ritratto
Francesca Interlenghi: Mi puoi parlare della genesi e dello sviluppo della tua ricerca? Da cosa nasce questa urgenza di indagarsi innanzitutto, di mettere il proprio corpo a servizio della pratica artistica?
Caterina Notte: Nasce tutto da un senso di fragilità che ho sempre percepito come donna e nel mio corpo di donna. Dalla percezione di alcuni limiti che io avvertivo molto forti e dalla consapevolezza di certe paure: quella di cambiare per esempio, quella del corpo che cambia, o quella delle relazioni con l’altro, il pericolo di dipendere da esse. Sensazioni che mi hanno portata ad analizzare in maniera approfondita il tema della fragilità, che è molto connessa, nel mio caso, all’osservazione intesa soprattutto come parte di un ciclo di ri-osservazione. Nel senso che io come soggetto, soprattutto come soggetto femminile, osservo la realtà, mi osservo, gli altri mi osservano, io mi ri-osservo nuovamente, in un ciclo che è molto limitante e ingabbiante. Il mio scopo è quello di provare a liberarmi da questo ciclo. Nel libro che sto per pubblicare “La caduta dell’osservatore nella pratica della debolezza”, edito da Le piccole pagine, ho raccolto le mie riflessioni in merito insieme a quelle di altri 14 studiosi nazionali e internazionali (antropologi, fisici, sociologi, filosofi) con l’obiettivo di eliminare, almeno metaforicamente, l’osservatore, proprio per uscire da questa spirale continua del processo di osservazione, che ci limita e ci rende fragili anche come corpi. Una scelta di libertà, che mira a recuperare quel massimo di libertà che, con la nascita, ci siamo conquistati e che poi, lungo il corso della vita, abbiamo perduto. Tutte le scelte che siamo costretti a fare, se ben indirizzate, ci possono aiutare a recuperare quella libertà. Quindi la scelta per me è libertà. Perché nel momento in cui ci troviamo di fronte alla nostra scelta significa che abbiamo già accesso a un pezzetto della nostra libertà. In questo senso la fragilità non mi fa paura, nella misura in cui sono riuscita a trasformarla in forza, in questa potenza.
Francesca: L’uso della tecnologia a favore dell’indagine su te stessa ti porta, nel 2005, ad essere selezionata dalla Fondazione Ratti tra gli artisti partecipanti al laboratorio di ricerca condotto da Alfredo Jaar “The Aesthetic of Resistence”. Un’esperienza che ha segnato una svolta importante nella tua pratica, stimolandoti in qualche modo a spostare l’attenzione dal tuo corpo a quello altrui. Non a caso pochi anni dopo, nel 2009, vede la luce il tuo progetto Predator.
Caterina: Quell’esperienza ha amplificato in me l’urgenza di agire come artista, il sentimento di responsabilità verso il mondo e verso la società. Ho capito che dovevo cambiare Da me sono passata a soggetti altri, altre donne, ragazze e bambine, nelle quali con il tempo ho smesso perfino di ricercare una certa fisionomia simile alla mia. Erano corpi altri. E così è iniziato Predator, anche un po’ per caso a dire la verità. Un giorno mi sono ritrovata in una campagna desolata insieme a 4 bambine e un furgoncino azzurro. Dovevo scattare delle foto ma non avevo ancora ben chiaro che cosa fare. Poi, senza un’apparente ragione, tirando fuori delle cose del mio zaino, ho trovato delle garze, che portavo sempre con me nel caso in cui fossi fatta male. Ho pensato di bendare, letteralmente garzare, queste bambine. Loro si sono entusiasmate, sono entrate nel furgoncino e si sono messe alla guida. Per me era come assistere a un film, non ero nemmeno più io a dirigere. Riguardando le immagini di quella giornata mi sono accorta che in effetti qualcosa era profondamente cambiato. La fragilità, che era sempre stato un tema a me caro, e alla quale avevo cercato di sopperire con la tecnologia e la realtà aumentata, superando i limiti dell’umano e del possibile, grazie a queste bambine mi sembrava si fosse trasformata in potenza. Loro avevano completamente preso in mano la scena e io in qualche modo l’avevo subita, ne ero diventata vittima. In un inatteso ribaltamento di ruoli.
© Caterina Notte, Predator #333
Francesca: L’elemento della garza è ricorrente nella tua poetica. Non si tratta di un ornamento estetico ma di un elemento profondamente connesso alle tue origini e ai ricordi della tua infanzia.
Caterina: Ci sono molti riferimenti alla mia terra, il Molise, e ai legami, anche quelli della mia infanzia. Ai neonati era usanza far indossare, per un anno intero, i cordoni di San Francesco. Era toccato anche a me. Oppure si usava fasciarli con le garze bianche, per mantenere la colonna vertebrale ben dritta. Le garze mi riportano ai luoghi in cui sono cresciuta, al ricordo di mia nonna che andava nei campi con i polpacci fasciati di garze, sempre bianche, sempre linde. Ma, soprattutto ultimamente, questo elemento si sta sviluppando anche in altro modo, come azione sociale nei luoghi aperti e nei luoghi pubblici, sotto forma di piccole proteste molto intime, che cercano di rendersi visibili in questa società super controllata, super sorvegliata in cui viviamo. Quest’anno per esempio, come fosse un’estensione di Predator, ho iniziato la serie Die Reise eines Mädchens (Il Viaggio di una Bambina). Si tratta di un viaggio verso Monaco, intrapreso con mia figlia, che invece di avere il viso ricoperto di garze tiene in mano dei cartelli, quelli di cartone tipici delle proteste, avvolti da garze, sui quali lei scrive di messaggi. Li espone in luoghi pubblici, per esempio nei musei, nel tentativo di renderli visibili con un atto di protesta agito in maniera intima, quasi raccolta.
© Caterina Notte, Predator #300
Francesca: Mi puoi parlare dell’installazione sonora “La mia voce dentro il mare” che presenti a Reggio Emilia, a Binario49, in occasione di questo progetto espositivo?
Caterina: L’installazione è a sua volta un’estensione di questi atti di protesta. Al centro della sala il pavimento è ricoperto di sale grosso e vi è una semplice pedana di legno sulla quale è appoggiato un megafono, quello che si usa nelle proteste appunto. Dal megafono escono le voci di alcune bambine, che leggono o urlano ad alta voce frasi che ho tratto dai discorsi di Gandhi, frasi molto semplici, non necessariamente quelle d’effetto o più note, dalle quali emerge in maniera ancora più evidente la sua umanità. Le bambine le leggono, a volte gridando, a volte dimostrandosi impacciate, con la loro forza di bambine che fuoriesce da questo megafono. Tutto il lavoro è ispirato a Gandhi e alla marcia del sale. Il visitatore, entrando nella sala, è costretto a partecipare a questa protesta, anche semplicemente calpestando il sale. Come a dire che ognuno di noi può essere parte, anche con un granello di sale, del cambiamento. In aggiunta, la ripetizione in loop delle voci, che dicono e ridicono le frasi come per farle capire meglio, è un’ulteriore monito per lo spettatore. Il sottofondo sonoro è costituito dalla registrazione, che ho fatto alla stazione di Monaco di Baviera, delle voci dei profughi che arrivavano dall’Ucraina. Un viaggio che inizia con il rumore del treno e finisce con il mare, con il verso del gabbiano, a ricordare la marcia di Gandhi.
© Caterina Notte, Die Reise eines Mädchen #1
Francesca: Parli di cambiamento e allora voglio chiederti, per concludere, qual è il ruolo che attribuisci all’arte e se c’è una funzione sociale che riconosci a te stessa come artista.
Caterina: L’arte può cambiare la realtà nella misura in cui può lasciare dei solchi, delle tracce che rimangono. In questo senso mi ritengo responsabile in tutto quello che faccio. Quando lavoro con delle bambine, per esempio, mi sento molto responsabile nei loro confronti per le conseguenze che partecipare ai miei progetti può avere nel loro modo di fare o di pensare. Ma avverto che è necessario, come artista, che io agisca in questo senso. Se non si lasciano delle tracce, se non si scavano dei solchi, nulla resta e nulla cambia. Ecco perché è importante, per me, che ci sia un’azione oltre all’immagine, oltre al prodotto estetico che può avere valenza documentaristica. La mia responsabilità è quella di lasciare una traccia che altri possano seguire. Così come io sto seguendo le tracce lasciate da altri, proseguendo una resistenza che è stata condotta prima di me. Non è solo la mia resistenza, è quella di altri che mi hanno preceduta, che hanno scavato una traccia che io sto continuando a scavare. Questo mi interessa: le crepe, i solchi, le tracce.
© Caterina Notte, Die Reise eines Mädchen #13
Cover story: © Caterina Notte, Die Reise eines Mädchen #10